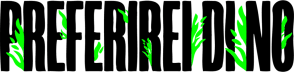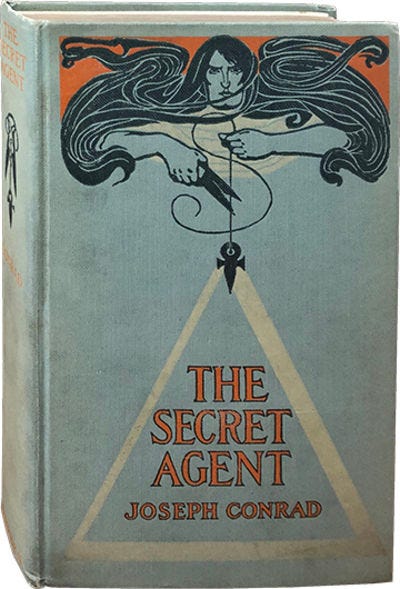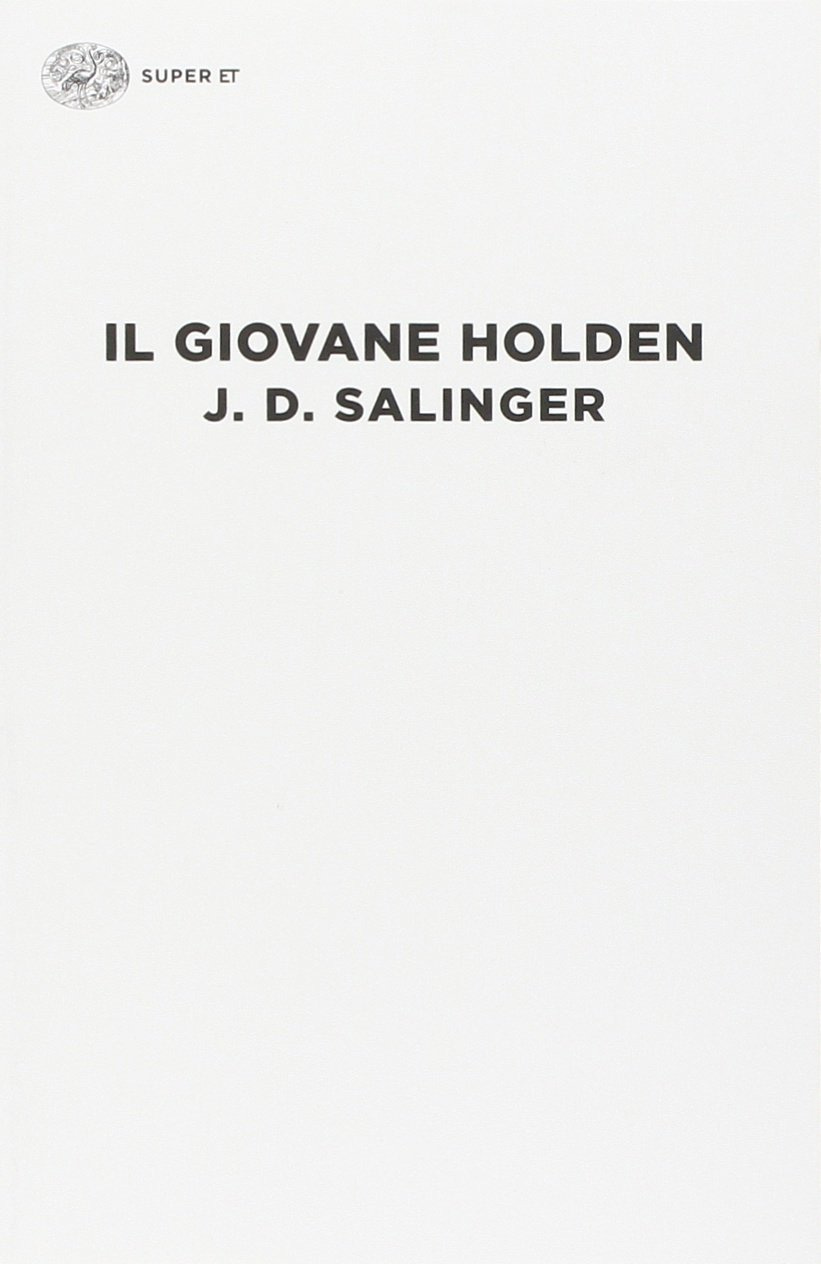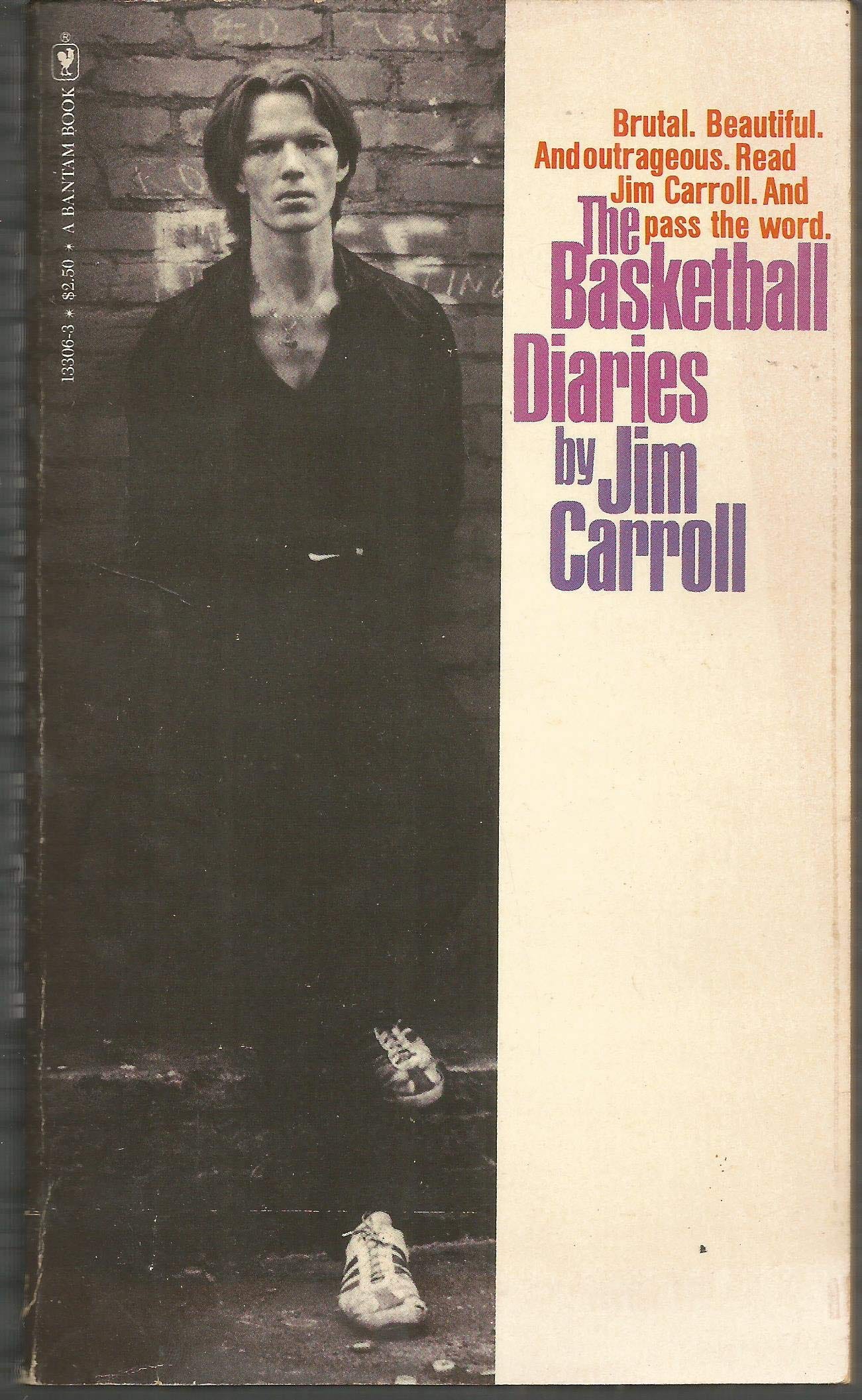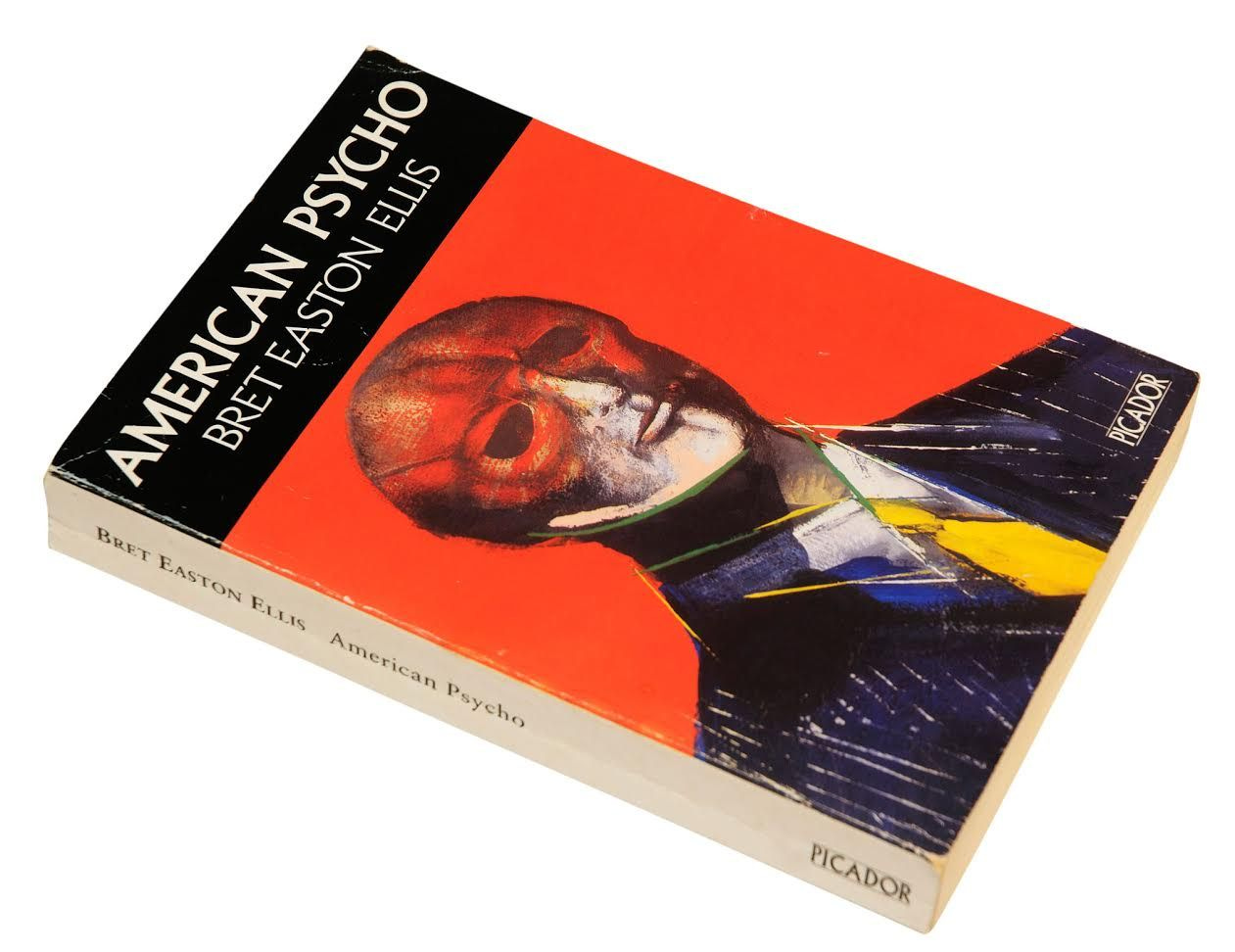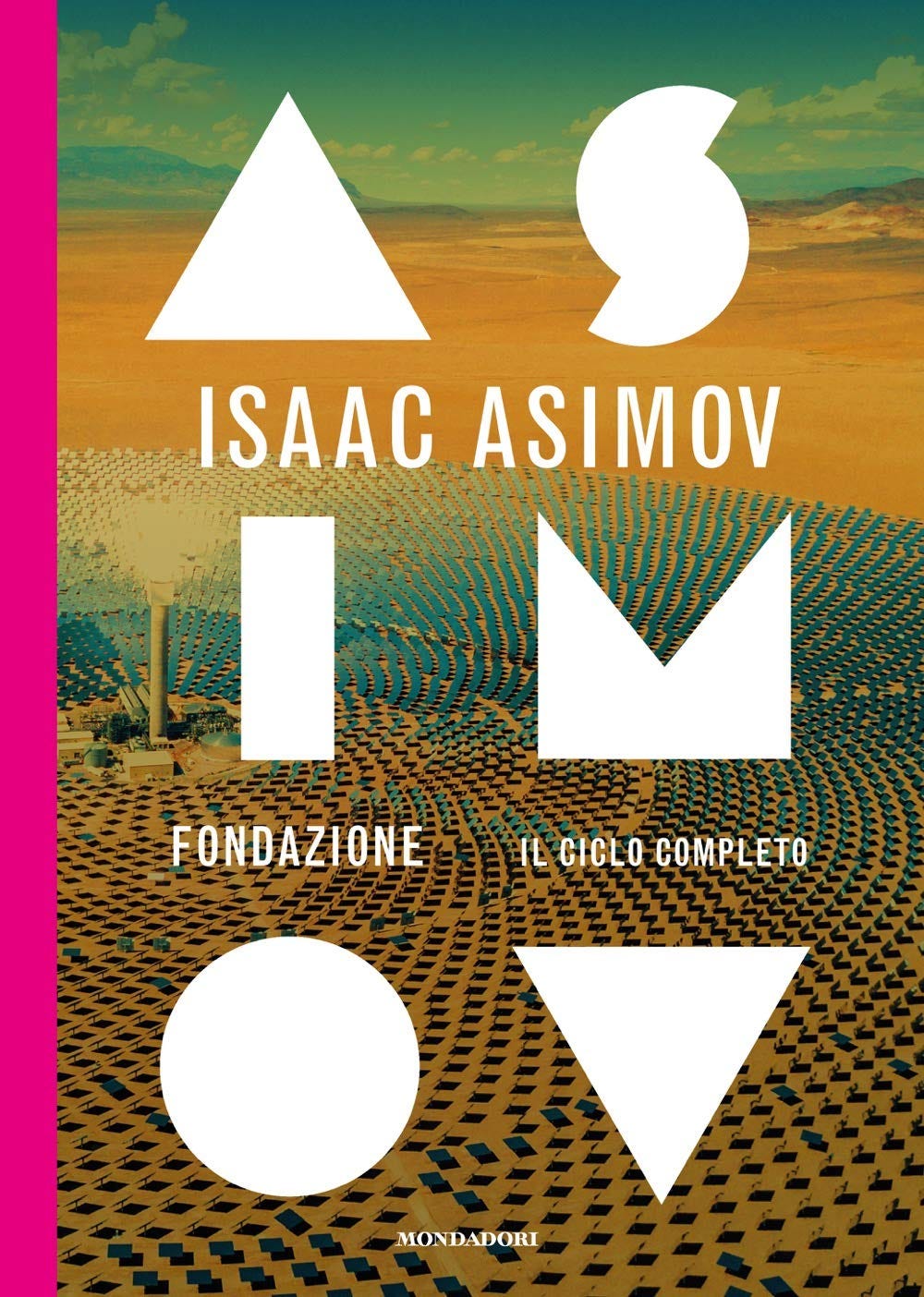Per quel che ci riguarda, siamo cresciuti con dei genitori che hanno tentato invano di spegnerci la Playstation e metterci in mano qualche libro di Calvino o di Jules Verne. Volevano che leggessimo, quei pazzi. A quei tempi eravamo ancora sani di mente e ci facevano schifo i libri, perché ci ricordavano la scuola, le istituzioni, le regole, la pazienza, e credevamo che ci arricchissero, che avessero una qualche utilità morale, che ci rendessero persone migliori: questa è l’impalcatura retorica che ha costruito l’industria culturale per venderti la sua paccottiglia letteraria. Ma in piena pubertà tutto ciò che ti fa bene ti ripugna, la scuola è una prigione e tu vorresti soltanto dilapidarti invece di arricchirti, fare del tuo corpo una macchina da scontro. Scontrarti con qualsiasi cosa, sentire che suono fa la vita quanto ti sbatte addosso e sei indifeso. E quando non si poteva uscire in strada, Call of duty era meglio dei libri come simulazione. Almeno era quello che credevamo, fortunatamente. Perché poi, più tardi, i libri li abbiamo scoperti sul serio. La pubertà era finita e ormai ci inoltravamo nell’età adulta schivando parecchie letture scolastiche. Ma è stato durante un Natale qualunque, in una di quelle giornate di pioggia dove l’ottundimento che segue alle feste ti ovatta il cervello e le ore sembrano non passare più e non hai voglia di uscire né di guardare un film. È stato allora che abbiamo preso in mano un libro in totale autonomia, disinteressatamente, per la prima volta. Che ci sarà poi di speciale in questi libri? Ci sediamo e cominciamo a sfogliare, poi a leggere, poi ci finiamo dentro, come storditi. Ma che roba è questa? Si apre una porta dentro di noi. Il nostro orizzonte interiore scala di qualche centimetro. C’è più spazio adesso, ci sono più parole, ci sono più mondi, c’è più vita della vita e non si torna più indietro. Se quella porta si apre, se una frase scritta bene è la chiave per la tua serratura, allora è finita. I confini della nostra coscienza cominciano ad espandersi. Sensazione strana, assurda, mai provata prima, quando eravamo costretti nel nostro monolocale, arredato solo da ciò che era immediatamente visibile. Tra gli slogan di Feltrinelli ce n’è uno ispirato a una frase di Umberto Eco: chi non legge vive solo la propria vita, chi legge invece ne vive mille. Quelli di Feltrinelli pensano sia uno slogan carino, lo mettono sui segnalibri, sulle shopper. Gli psichiatri, invece, la chiamano schizofrenia. Nonostante gli operatori del settore culturale, editori, giornalisti, direttori di fiere e festival, caporedattori, critici, editor e via discorrendo, (e i nostri genitori a fare da eco) incentivino i giovani a leggere - convinti che la lettura sia edificante - in realtà non hanno capito che questa attività può degenerare in patologia, portare a disforie mentali, indurre ad allucinazioni, come una droga. Oltre a essere una condotta anti-sociale al massimo (se la Playstation è un’attività che si può svolgere al plurale, leggere si fa sempre al singolare), la lettura è anche pericolosa, la cultura in generale è pericolosa, e oltre ad aver prodotto capolavori assoluti e grandi e lodevoli imprese, ha generato spesso conflitti e catastrofi. È in nome dei libri sacri, come la Torah, la Bibbia o il Corano, che si sono innalzate le chiese più belle ma anche indetti i peggiori massacri della storia. Hitler aveva 16.000 volumi nella sua biblioteca - chissà che l’Istat non lo consideri un lettore forte. Il Manifesto di Marx e Engels, per citare l’esempio più celebre, ha causato rivolte e rivoluzioni. La lettura è una roba da spostati, da deviati mentali. La letteratura stessa ne dà prova. Il Don Chisciotte, infatti, impazzisce per le troppe ore passate sui libri, l’amore folle nutrito dal giovane Werther è alimentato dalle letture dei Canti di Ossian, Madame Bovary viene colpita dal male dell’immaginazione dopo aver passato l’adolescenza tra romanzi dozzinali. Eppure, gli operatori editoriali mettono cuscini, gattine e tisane tra noi e la lettura, conferiscono una qualche utilità morale all’oggetto libro, disinnescando tutto il potenziale eversivo della parola e della cultura in generale. Il Ministero del Turismo con la sua nuova e raccapricciante campagna ideata dal team della Santanché, “Open to meraviglia” è la massima apologia di questa retorica quando apparecchia questa festa di vuoti cliché, riducendo l’Italia all’idea che ne ha un americano medio, banalizzando una storia millenaria.
Con quale disinvoltura invitiamo milioni di persone a visitare Chiese dove venivano battezzati uomini pronti a partire per le Crociate in Terra Santa a perpetuare uno sterminio, o a fotografare anfiteatri dove migliaia di schiavi sono stati sbranati da leoni per il puro divertimento della folla? Tutta l’iconografia medievale e rinascimentale che decantiamo e di cui il MT fa il suo core business, ha come temi principali la morte del Cristo, i dolori della Madonna addolorata, la vita degli apostoli e dei santi, spesso morti atrocemente - scuoiati, messi al rogo, sgozzati - e noi scattiamo selfie sullo sfondo di affreschi che immortalano omicidi di tutti i tipi, fratricidi, matricidi, parricidi, convinti che tutto ciò sia in qualche modo educativo. Confondendo la cultura con la bellezza, limitando ogni opera a muta testimonianza del passato, facendo della lettura solo un’attività ricreativa, annientiamo tutta la potenza sovversiva di queste dimensioni. Se diventano edificanti, vuol dire che non ci parlano più, se non riusciamo a inginocchiarci e a piangere di fronte a un cristo di Mantegna, se finito di leggere Dostojevskij non vorremo anche noi uccidere una vecchia ma invece lasciamo una recensione su Amazon, uscendone migliorati, compiaciuti, come se avessimo spuntato in agenda anche questa esperienza fatta, allora la cultura è già villeggiatura, una passeggiata domenicale da fare in ciabatte, un passatempo rilassante, consigliato dal medico o dallo psicologo, puro intrattenimento, riduzione a quello spettacolo che per Debord rappresenta “il brutto sogno della società moderna incatenata, che infine non esprime altro che il suo desiderio di dormire”. Leggere, invece, è un'attività che radicalizza, leggere può far diventare pazzi, leggere porta a compiere anche azioni riprovevoli, leggere non fa bene, non ci migliora, non ci edifica ma ci annienta, può mandare all’aria un’esistenza, può farci innamorare o disamorare, con tutte le sofferenze che questo comporta, può farci partire o restare, creare mondi e distruggerne di altri, può farci vivere da santi o peccatori, e sopprimere una di queste alternative vuol dire mutilare il nostro modo di essere nel mondo, privandoci di vedere il male che c’è nel bene e il bene che c’è nel male. Tutto questo siluro per dire che il potere, così come è sempre accaduto nella storia, dovrebbe temere la cultura e aver paura di chi legge. Mentre noi abbiamo uno Stato, con tutto il suo apparato culturale, che incentiva la lettura. Se lo fa, vuol dire che la parola non ha più peso, che le ideologie sono morte, che non si può più agire sulla realtà e che tutto è già deciso altrove, da una megamacchina tecno-burocratica a cui abbiamo appaltato ogni scelta, e che ha come unico scopo quello di riprodurre se stessa. Noi vorremmo che la parola tornasse ad avere quel peso, quel potere afrodisiaco su individui e collettività, la capacità di modificare destini, di far sollevare i popoli, inaugurare rivoluzioni - senza cui il mondo diventerà uno spazio piatto e indistinto, igienizzato e bonificato dalla dimensione tragica dell’esistenza, dove leggeremo libri scritti da ChatGPT, cercando di capire perché non proviamo più niente.
Assassino chi legge
o dei pericoli della letteratura
L’agente segreto di Joseph Conrad (1907) / 3 morti e 23 feriti
Ted Kaczynski, l’Unabomber che Netflix ha portato alla ribalta, aveva letto una dozzina di volte L’Agente segreto di Conrad, ne era ossessionato. Il libro parla, guarda caso, di attentati terroristici e di strategia della tensione. Kaczynski poi, ispirandosi al “Professore” del romanzo, si era dato al bosco, luogo da dove orchestrava i suoi attentati contro il mondo moderno.
Il Giovane Holden, di J. D. Salinger (1951) / 5 morti
Mark Chapman, l’assassino di John Lennon, andava pazzo per il Giovane Holden, pensava che il libro di Salinger meritasse una conclusione rituale. Per questo motivo acquistò una pistola, si diresse a New York, aspettò sotto l’appartamento di John Lennon - il “venduto”, il falso profeta, il tipico phonie delle invettive di Holden Caufield – si fece fare un autografo e gli esplose sei colpi, mortali, alle spalle. Poi si adagiò con calma su un muretto, in attesa della polizia, e tirò fuori una copia tascabile del suo romanzo preferito. Mentre leggeva un agente gli chiese retoricamente: “ti rendi conto di quello che hai fatto?”. La risposta, ugualmente retorica: “Ho appena ucciso John Lennon”. Seguirono 4 suicidi di fan dei Beatles.
The Basketball Diaries di Jim Carroll (1995) / 15 morti e 23 feriti
I grandi romanzi riescono a cogliere lo spirito del tempo. C’è una splendida scena in Basketball Diaries in cui Carroll sogna di entrare in classe durante l’ora di inglese e sparare all’impazzata colpi di fucile sui suoi compagni. Erano ancora tempi non sospetti, era prima di Columbine. Anzi fu questo libro a ispirare il più famoso dei massacri in una scuola degli USA (12 morti e 23 feriti) oltre a quello di Denver (3 morti), inaugurando la stagione delle stragi.
American Psycho, di Bret Easton Ellis (1991) / 2 morti.
Rurik Jutting a detta dei suoi amici idolatrava il Patrick Bateman del romanzo di Ellis, voleva essere lui. Lavorava in finanza - guarda caso – e aveva una passione per il massacro di prostitute. Una sera ad Hong Kong invitò due ragazze nel suo appartamento, le picchiò a sangue e poi le accoltellò in preda a un delirio di onnipotenza ispirato al suo romanzo preferito.
Fondazione di Isaac Asimov (1951) / 12 morti e 5000 feriti ca.
Nella fortunata serie di Asimov il protagonista forma una società segreta con l’obiettivo di rifondare l’umanità dopo l’apocalisse. Alla sua morte il suo pensiero si trasforma in religione. Shoko Asahara insieme a 100 seguaci, invece, ne trassero spunto per fondare una setta terroristica, specializzata nello spargere gas nervino nella metro di Tokyo. Le tesi della setta furono direttamente ispirate dalla serie di Asimov.
Poesie a buffo
Se ni' mondo ci fosse un po' di bene
e ognuno si considerasse suo fratello,
ci sarebbero meno pensieri e meno pene,
e il mondo ne sarebbe assai più bello.
Pietro Pacciani, Poesie da un'aula di tribunale